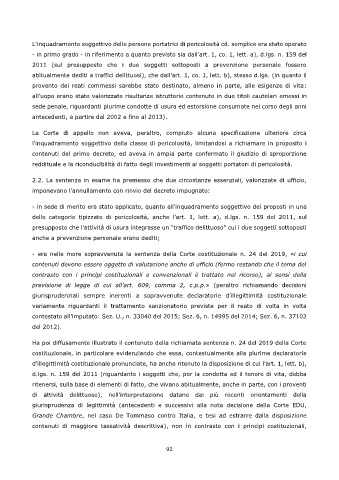Page 100 - Bollettino I Semestre 2019
P. 100
L'inquadramento soggettivo delle persone portatrici di pericolosità cd. semplice era stato operato
- in primo grado - in riferimento a quanto previsto sia dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del
2011 (sul presupposto che i due soggetti sottoposti a prevenzione personale fossero
abitualmente dediti a traffici delittuosi), che dall’art. 1, co. 1, lett. b), stesso d.lgs. (in quanto il
provento dei reati commessi sarebbe stato destinato, almeno in parte, alle esigenze di vita:
all’uopo erano state valorizzate risultanze istruttorie contenute in due titoli cautelari emessi in
sede penale, riguardanti plurime condotte di usura ed estorsione consumate nel corso degli anni
antecedenti, a partire dal 2002 e fino al 2013).
La Corte di appello non aveva, peraltro, compiuto alcuna specificazione ulteriore circa
l'inquadramento soggettivo della classe di pericolosità, limitandosi a richiamare in proposito i
contenuti del primo decreto, ed aveva in ampia parte confermato il giudizio di sproporzione
reddituale e la riconducibilità di fatto degli investimenti ai soggetti portatori di pericolosità.
2.2. La sentenza in esame ha premesso che due circostanze essenziali, valorizzate di ufficio,
imponevano l’annullamento con rinvio del decreto impugnato:
- in sede di merito era stato applicato, quanto all'inquadramento soggettivo dei proposti in una
delle categorie tipizzate di pericolosità, anche l’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, sul
presupposto che l'attività di usura integrasse un “traffico delittuoso” cui i due soggetti sottoposti
anche a prevenzione personale erano dediti;
- era nelle more sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, «i cui
contenuti devono essere oggetto di valutazione anche di ufficio (fermo restando che il tema del
contrasto con i principi costituzionali e convenzionali è trattato nel ricorso), ai sensi della
previsione di legge di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p.» (peraltro richiamando decisioni
giurisprudenziali sempre inerenti a sopravvenute declaratorie d’illegittimità costituzionale
variamente riguardanti il trattamento sanzionatorio previste per il reato di volta in volta
contestato all’imputato: Sez. U., n. 33040 del 2015; Sez. 6, n. 14995 del 2014; Sez. 6, n. 37102
del 2012).
Ha poi diffusamente illustrato il contenuto della richiamata sentenza n. 24 del 2019 della Corte
costituzionale, in particolare evidenziando che essa, contestualmente alla plurime declaratorie
d’illegittimità costituzionale pronunciate, ha anche ritenuto la disposizione di cui l’art. 1, lett. b),
d.lgs. n. 159 del 2011 (riguardante i soggetti che, per la condotta ed il tenore di vita, debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi
di attività delittuose), nell’interpretazione datane dai più recenti orientamenti della
giurisprudenza di legittimità (antecedenti e successivi alla nota decisione della Corte EDU,
Grande Chambre, nel caso De Tommaso contro Italia, e tesi ad estrarre dalla disposizione
contenuti di maggiore tassatività descrittiva), non in contrasto con i principi costituzionali,
92