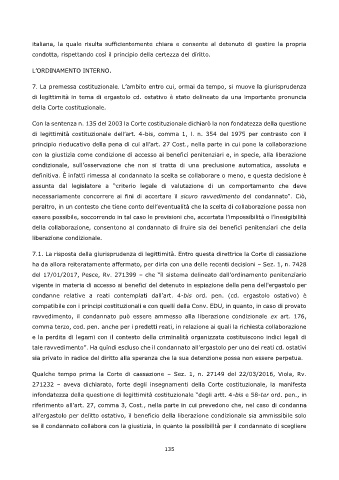Page 143 - Bollettino I Semestre 2019
P. 143
italiana, la quale risulta sufficientemente chiara e consente al detenuto di gestire la propria
condotta, rispettando così il principio della certezza del diritto.
L’ORDINAMENTO INTERNO.
7. La premessa costituzionale. L’ambito entro cui, ormai da tempo, si muove la giurisprudenza
di legittimità in tema di ergastolo cd. ostativo è stato delineato da una importante pronuncia
della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 135 del 2003 la Corte costituzionale dichiarò la non fondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, l. n. 354 del 1975 per contrasto con il
principio rieducativo della pena di cui all’art. 27 Cost., nella parte in cui pone la collaborazione
con la giustizia come condizione di accesso ai benefici penitenziari e, in specie, alla liberazione
condizionale, sull’osservazione che non si tratta di una preclusione automatica, assoluta e
definitiva. È infatti rimessa al condannato la scelta se collaborare o meno, e questa decisione è
assunta dal legislatore a “criterio legale di valutazione di un comportamento che deve
necessariamente concorrere ai fini di accertare il sicuro ravvedimento del condannato". Ciò,
peraltro, in un contesto che tiene conto dell’eventualità che la scelta di collaborazione possa non
essere possibile, soccorrendo in tal caso le previsioni che, accertata l’impossibilità o l’inesigibilità
della collaborazione, consentono al condannato di fruire sia dei benefici penitenziari che della
liberazione condizionale.
7.1. La risposta della giurisprudenza di legittimità. Entro questa direttrice la Corte di cassazione
ha da allora reiteratamente affermato, per dirla con una delle recenti decisioni – Sez. 1, n. 7428
del 17/01/2017, Pesce, Rv. 271399 – che “il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario
vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per
condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è
compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato
ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176,
comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione
e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di
tale ravvedimento”. Ha quindi escluso che il condannato all’ergastolo per uno dei reati cd. ostativi
sia privato in radice del diritto alla speranza che la sua detenzione possa non essere perpetua.
Qualche tempo prima la Corte di cassazione – Sez. 1, n. 27149 del 22/03/2016, Viola, Rv.
271232 – aveva dichiarato, forte degli insegnamenti della Corte costituzionale, la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale “degli artt. 4-bis e 58-ter ord. pen., in
riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevedono che, nel caso di condanna
all'ergastolo per delitto ostativo, il beneficio della liberazione condizionale sia ammissibile solo
se il condannato collabora con la giustizia, in quanto la possibilità per il condannato di scegliere
135