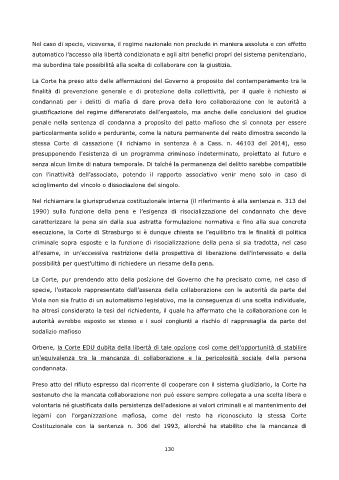Page 138 - Bollettino I Semestre 2019
P. 138
Nel caso di specie, viceversa, il regime nazionale non preclude in maniera assoluta e con effetto
automatico l’accesso alla libertà condizionata e agli altri benefici propri del sistema penitenziario,
ma subordina tale possibilità alla scelta di collaborare con la giustizia.
La Corte ha preso atto delle affermazioni del Governo a proposito del contemperamento tra le
finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività, per il quale è richiesto ai
condannati per i delitti di mafia di dare prova della loro collaborazione con le autorità a
giustificazione del regime differenziato dell’ergastolo, ma anche delle conclusioni del giudice
penale nella sentenza di condanna a proposito del patto mafioso che si connota per essere
particolarmente solido e perdurante, come la natura permanente del reato dimostra secondo la
stessa Corte di cassazione (il richiamo in sentenza è a Cass. n. 46103 del 2014), esso
presupponendo l’esistenza di un programma criminoso indeterminato, proiettato al futuro e
senza alcun limite di natura temporale. Di talché la permanenza del delitto sarebbe compatibile
con l’inattività dell’associato, potendo il rapporto associativo venir meno solo in caso di
scioglimento del vincolo o dissociazione del singolo.
Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale interna (il riferimento è alla sentenza n. 313 del
1990) sulla funzione della pena e l’esigenza di risocializzazione del condannato che deve
caratterizzare la pena sin dalla sua astratta formulazione normativa e fino alla sua concreta
esecuzione, la Corte di Strasburgo si è dunque chiesta se l’equilibrio tra le finalità di politica
criminale sopra esposte e la funzione di risocializzazione della pena si sia tradotta, nel caso
all’esame, in un’eccessiva restrizione della prospettiva di liberazione dell’interessato e della
possibilità per quest’ultimo di richiedere un riesame della pena.
La Corte, pur prendendo atto della posizione del Governo che ha precisato come, nel caso di
specie, l’ostacolo rappresentato dall’assenza della collaborazione con le autorità da parte del
Viola non sia frutto di un automatismo legislativo, ma la conseguenza di una scelta individuale,
ha altresì considerato la tesi del richiedente, il quale ha affermato che la collaborazione con le
autorità avrebbe esposto se stesso e i suoi congiunti a rischio di rappresaglia da parte del
sodalizio mafioso
Orbene, la Corte EDU dubita della libertà di tale opzione così come dell'opportunità di stabilire
un'equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale della persona
condannata.
Preso atto del rifiuto espresso dal ricorrente di cooperare con il sistema giudiziario, la Corte ha
sostenuto che la mancata collaborazione non può essere sempre collegata a una scelta libera e
volontaria né giustificata dalla persistenza dell’adesione ai valori criminali e al mantenimento dei
legami con l'organizzazione mafiosa, come del resto ha riconosciuto la stessa Corte
Costituzionale con la sentenza n. 306 del 1993, allorché ha stabilito che la mancanza di
130