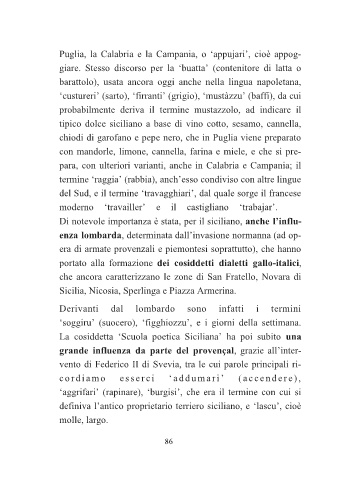Page 86 - LA SICILIA - Cesare Ferrara
P. 86
Puglia, la Calabria e la Campania, o ‘appujari’, cioè appog-
giare. Stesso discorso per la ‘buatta’ (contenitore di latta o
barattolo), usata ancora oggi anche nella lingua napoletana,
‘custureri’ (sarto), ‘firranti’ (grigio), ‘mustàzzu’ (baffi), da cui
probabilmente deriva il termine mustazzolo, ad indicare il
tipico dolce siciliano a base di vino cotto, sesamo, cannella,
chiodi di garofano e pepe nero, che in Puglia viene preparato
con mandorle, limone, cannella, farina e miele, e che si pre-
para, con ulteriori varianti, anche in Calabria e Campania; il
termine ‘raggia’ (rabbia), anch’esso condiviso con altre lingue
del Sud, e il termine ‘travagghiari’, dal quale sorge il francese
moderno ‘travailler’ e il castigliano ‘trabajar’.
Di notevole importanza è stata, per il siciliano, anche l’influ-
enza lombarda, determinata dall’invasione normanna (ad op-
era di armate provenzali e piemontesi soprattutto), che hanno
portato alla formazione dei cosiddetti dialetti gallo-italici,
che ancora caratterizzano le zone di San Fratello, Novara di
Sicilia, Nicosia, Sperlinga e Piazza Armerina.
Derivanti dal lombardo sono infatti i termini
‘soggiru’ (suocero), ‘figghiozzu’, e i giorni della settimana.
La cosiddetta ‘Scuola poetica Siciliana’ ha poi subito una
grande influenza da parte del provençal, grazie all’inter-
vento di Federico II di Svevia, tra le cui parole principali ri-
cordi amo es serci ‘addumari ’ (accendere),
‘aggrifari’ (rapinare), ‘burgisi’, che era il termine con cui si
definiva l’antico proprietario terriero siciliano, e ‘lascu’, cioè
molle, largo.
86